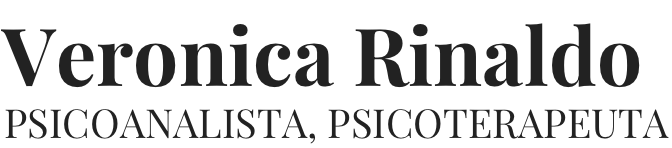Il film Vita di Adele, del regista A. Kechiche, ci dà degli spunti interessanti per mettere in questione la rottura amorosa e i suoi rapporti con il godimento e il desiderio.
A lezione di letteratura, Adele giovane 17enne, nel risveglio adolescenziale al crocevia della pulsione e dell’amore, si interessa alla “La vita di Marianna” di P.de Marivaux:
“Come ve lo spiegate che al cuore manca qualcosa?”. La sua prima esperienza con l’altro sesso, l’avvicinamento sul piano dell’intimità fisica e verbale convoca A. a quel “manca qualcosa”, che espone a un’amplificazione del turbamento piuttosto che a un suo appianamento. Sarà per lei insopportabile e sceglierà, per questo motivo, di rompere velocemente per andare verso una scelta oggettuale che, in virtù di un’apparente concordanza, che non fa posto né al turbamento né al vuoto, le assicura il suo godimento privilegiato: “mangio la pelle di tutto” dirà ad Emma, al loro primo incontro.
Le inquadrature rendono magistralmente il legame di A. tra lo sguardo e la pelle divorabile del corpo della partner, attraverso il tratto della sua bocca sempre dischiusa.
“Se è vero […] che l’Altro si raggiunge solo congiungendosi ad a, alla causa del desiderio, è comunque al sembiante d’essere che l’amore si rivolge. Questo essere non è poca cosa. È presupposto all’oggetto che costituisce la a”[1]. Nel film nonostante trascorrano gli anni e sopraggiunga l’adultità, per Adele nulla cambierà, non farà spazio alla mancanza rinunciando a un po’ di quel godimento vorace che la tiene attaccata al corpo di Emma, e di fronte alle perplessità della partner risponderà: “ho te e mi basta”. In questi passaggi del film si può leggere bene che “Benché sia reciproco l’amore è impotente, perché ignora di non essere altro che il desiderio di fare Uno, il che conduce all’impossibilità di stabilire la loro relazione. La relazione di loro chi? Dei due sessi”[2] .
Tra i sessi la discordanza, termine che Lacan prende dalla matematica, è indipendente dall’anatomia dei partner. Così, basterà che uno sguardo incrini il miraggio di completezza e concordanza, perché A. vada ad assicurarsi altrove una risposta alla sua insaziabilità. La rottura arriva lì dove non è più possibile ignorare che il desiderio di fare Uno non trova la sua impronta corrispondente nel Due della differenza tra i partner, ciò che in altri termini diciamo con la formula dell’impossibile: “non c’è rapporto sessuale”. C’è da arrangiarsi rispetto all’impossibile, e spesso nel punto vuoto che convoca un arrangiamento avviene piuttosto una rottura. In un incontro d’addio mentre E. racconterà della sua nuova relazione, dove un meno sul lato del godimento fa posto al legame a due e finanche a tre, Adele ammetterà il suo disorientamento rispetto al legame amoroso: “volevo essere presa sul serio ma a quanto pare non basta un taglio”.
Affinché qualcosa dell’amore si articoli in un legame è necessario che il soggetto passi per la via precipua del taglio con l’Uno di godimento a cui non manca nulla, lasciando che si faccia avanti l’Uno- in- meno[3] , che fa posto all’alterità. Per alcuni soggetti acconsentire a questo è insopportabile e costoso tanto da prendere la via della fuga, della frattura; si potrebbero chiamare rotture amorose, ma preferisco chiamarle rotture pre-amorose.
Si incontrano nella clinica, in coloro che soffrono degli effetti di rispondere a un’urgenza pulsionale tramite un oggetto- partner, urgenza che mette sotto scacco l’amore, ed è particolarmente in linea con la cultura capitalista attuale, nella quale più che mai l’amore si oppone agli interessi della civiltà [4]. L’amore è antieconomico, poiché per dischiudere all’alterità del legame amoroso non c’è altro passaggio che perdere qualcosa di quel godimento che fissa fantasmaticamente all’oggetto; a volte il soggetto non è disposto a passare da quella perdita, che aprirebbe a una versione dell’amore diversa dalla sua forma feticista, ed è lì che colloco le rotture pre-amorose.
[1] J. Lacan, Il Seminario, Libro XX, Ancora [1972-1973], a cura di A. Di Ciaccia, Torino, Einaudi, 2011, p.87.
[2] Ivi, p.7.
[3] Ivi, p.123.
[4] S. Freud, “Il disagio della civiltà”, in Opere, vol.10, Bollati Boringhieri, Torino,1979, p. 239.