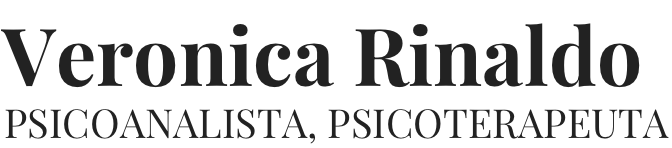Il termine «disrupzione» viene dall’elettrologia, si dice disruptiva una scarica elettrica dovuta ad un eccesso di tensione che manda in frantumi un isolante, il fulmine ne è un esempio.
Nel suo corso del 2011, L’Essere e l’Uno, Miller lo indica “come quell’incontro contingente tra significante e godimento che si può formulare come il reale senza legge. Quell’esperienza indimenticabile di godimento che sarà commemorata nella ripetizione, si tratta dell’effrazione, della rottura, della disrupzione rispetto a un ordine preliminare istituito dalla routine del discorso attraverso cui resistono le significazioni. Tale rottura si esprime con uno sregolamento che Freud ha catturato nel significato della castrazione e nel teatro dell’interdizione edipica”[1].
Che succede quando quest’effrazione di godimento non viene imbrigliata nel teatro edipico? Troviamo le rotture impossibili. Impossibili per il soggetto da articolare sulla scena, realizzate piuttosto nel reale. Abbiamo a che fare con un godimento fuori castrazione.
Il film Mommy, del regista Xavier Dolan, lo rappresenta in modo puntuale e drammatico. È la storia di un amore incestuoso tra un ragazzino fragile con diagnosi di ADHD e la madre. Incestuoso nella misura in cui l’uno si realizza come oggetto dell’Altro. “Non trovo le foto di papà!” sarà la sua prima esclamazione appena tornato a casa da un centro di recupero.
Siamo fermi alla fase che Lacan chiama alienazione, e non nella fase successiva, quella della separazione, ove l’oggetto a è messo nel campo dell’Altro e collocandosi come intersezione tra il soggetto e l’Altro introduce la dialettica simbolica, attraverso la dialettica degli oggetti del desiderio.
Steve è immerso in un godimento che gli è insopportabile, come gli è insopportabile al contempo perdere qualcosa di quel godimento, data la sua fragilità rispetto alla separazione; è oggetto del godimento di un Altro materno sregolato, che ne fa ora il destinatario di un’intimità senza limite ora l’oggetto cattivo di cui sbarazzarsi, da lasciar cadere. Ad ogni faglia che apre il Che vuoi? Steve incontra un buco, l’immagine si frantuma e esplodono gli attacchi violenti verso l’altro e verso sé stesso. L’Altro è rotto, e lui “sulla via del reale, incontra l’Uno, che è il residuo della disconnessione”[2].
La presenza ingombrante e claustrofobica dell’Uno è magistralmente resa dall’inquadratura 1:1 per tutta la durata del film, che, costringendo la ripresa di un solo personaggio per volta, trasmette l’isolamento, la solitudine e l’assenza di legame.
Solo in due momenti l’inquadratura sarà a tutto campo:
la prima è quando Steve formula la sua domanda di essere aiutato a prendere il diploma e a seguire il suo desiderio di fare una scuola d’arte, rivolgendosi a Kayla, la vicina di casa che, partner regolato e mancante, farà spazio al soggetto. S. studia, scrive, si apre la progettualità, si apre il desiderio soggettivo e l’inquadratura si estende al campo. Il disinserimento dall’oggetto consente, infatti, il fluire del tempo attraverso una narrazione dove il soggetto può inserirsi in quel luogo della scena, che, Lacan ci dice nel Seminario X (p.125), è il luogo in cui soltanto può mantenersi nel suo statuto di soggetto, come soggetto fondamentalmente storicizzato.
La seconda apertura dell’inquadratura è quando la madre fantastica su un figlio separato da lei, che diventa adulto e realizza i suoi progetti, mentre lo porta però a sua insaputa in un istituto psichiatrico[3]. Il sogno ad occhi aperti è risucchiato nel silenzio del posto non avvenuto della separazione, separazione che senza la mediazione simbolica diviene impossibile e si realizza nel reale con un passaggio all’atto: il soggetto si separa radicalmente dall’Altro con una rottura, in cui è lui stesso a frantumarsi poiché collassando sull’oggetto si fa scarto.
Nel film sono interessanti anche le sfasature nell’uso del suono, la musica è sempre altra, discordante rispetto alla narrazione, come a sottolineare che ciò che prevale nella sofferenza dei personaggi è proprio quel fuori rappresentazione, sfasato e slegato dalla parola.
[1] J.A. Miller e A. Di Ciaccia, L’Uno-tutto-solo, Astrolabio, Roma, 2018, pp.120-121.
[2] J.-A. Miller, L’orientation lacanienne. Le tout dernier Lacan, lezione del 21 marzo 2007.
[3] Nel film, il Canada ha approvato una controversa legge, denominata S-14, che consente ai genitori di minori difficili di effettuare un ricovero coatto presso un istituto psichiatrico, saltando la procedura legale.
https://xxiiconvegno2025.slp-cf.it/rotture/testi/rotture-impossibili/